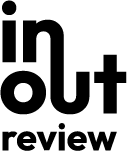In India è nota da millenni come Vastu-Karma. In Europa viene prediletta invece l’espressione Karma-design. Al di là delle locuzioni utilizzate, oggi l’architettura olistica torna a manifestarsi attraverso una delle sue creazioni più enigmatiche: il labirinto.
È la legge dei contrappesi: se la tecnologia opera per rimuovere dalla vita ogni forma di ostacolo o impedimento, lo spazio risponde frenandone la spinta centrifuga. Anche e soprattutto nel mondo dell’ospitalità, dove maggiore è l’esigenza di abbandonarsi alla leggerezza esistenziale. “Grazie alla possibilità di viaggi in ambienti estremi come le foreste primarie – osserva Giulia Meregalli, architetto e decoratrice d’interni attiva a Monza – chi è abituato a vivere in contesti urbani e a progettare spazi abitabili ha modo di sperimentare ancora il paradosso dello smarrirsi in natura, del girare a vuoto: un lusso quasi scomparso nella nostra società. Passare attraverso questa esperienza, però, è fondamentale per acquisire una diversa consapevolezza dei luoghi che siamo soliti frequentare senza più ‘riconoscerli’, perdendone in tal modo la complessità multisensoriale”.
A seguito di un soggiorno nello Stato brasiliano dell’Acre e nella microregione di Chapada dos Veadeiros, il fitto intrico vegetale ha piano piano iniziato a prendere forma nella stessa pittura di interni di Giulia Meregalli – abitazioni private, uffici e bar in Brianza all’inizio, per arrivare alle richieste di alberghi nelle propaggini del Salento – rivelando una crescente propensione dell’era postpandemica per sperimentare due tipi di ambienti labirintici.

Da quello figurativo indoor si passa, infatti, all’ambiente fisico outdoor, perché la riproduzione avvolgente e iperrealistica di piante erbacee o tropicali come rifiuto del white minimalist indoor si proietta all’esterno, in forma di continui piegamenti e ripiegamenti vegetali. “A dominare, in entrambi i casi – aggiunge Meregalli -, è l’idea di costante apertura/chiusura, di viabilità interrotta e di nuovo ripresa, segno di un’inquietudine contemporanea che metabolizza la rigidità geometrica delle partizioni attraverso la flessibilità delle forme naturali”.

A fare da apripista in Italia di questo nuovo sentire “sostenibile e neobarocco”, nel 2015, è stato il Labirinto della Masone a Fontanellato (Parma), il più grande del mondo con le sue 300mila piante di bambù alte tra i 30 centimetri e i 15 metri, al cui centro sono collocate due suite esclusive con opere di Franco Maria Ricci: la calma della ragione nella foresta del subconscio.
Nato nel 2015 dall’idea di Ricci e con il supporto degli architetti Pier Carlo Bontempi e Davide Dutto, oggi il Labirinto della Masone è un luogo psichedelico, in cui, oltre alle suite in cui è possibile pernottare, sono presenti una caffetteria, un museo con la collezione d’arte privata del suo creatore e un ristorante-bistrò.
Le declinazioni del concept del labirinto sono, tuttavia, ormai innumerevoli, grazie all’antica storia che contraddistingue le dimore nobiliari del Belpaese e che trova eco pari, forse, solo nel Regno Unito.
A rispondere alle suggestioni italiane in quest’ultimo Paese è l’hotel The Hampton Court Palace Maze, un dedalo ideato da George London ed Henry Wise nel 1700, praticamente in continuità con gli ambienti dell’elegantissimo hotel The Mitre. Di qualche anno più tardo è invece Palazzo di Varignana a Castel San Pietro Terme (Bologna), dove Sandro Ricci ha creato un Labirinto Carlico sovrapponendo siepi di ilatro (Phyllirea angustifolia) al ricco frutteto esistente. Agli ospiti del resort non viene offerta solo un’esperienza interiore di ri-centramento tramite le illusioni provocate dalle piante, ma anche di esplorazione dei sensi grazie ad essenze stimolanti appositamente scelte e coltivate. Ancor più sfidante appare il percorso associato all’hotel Magia del Brenta di Fiesso D’artico (Venezia), che fa degli eventi aziendali e delle attività di team building un naturale complemento dell’attiguo parco-labirinto di Villa Pisani a Stra.
La firma dell’opera è attribuita all’architetto padovano Girolamo Fringimelica de’ Roberti (1719), mentre il suo disegno è considerato tuttora il più difficile del mondo: qui fallì anche il genio strategico di Napoleone Buonaparte, messo in crisi da nove cerchi concentrici di alte siepi di bosso, nonostante al centro sia sempre ben visibile l’elegante torretta a doppia scala dedicata alla dea Minerva. Perdita. Dubbio. Bisogno impellente di risposte. Molteplici sono le esperienze psicologiche che il labirinto evoca e le strutture d’ospitalità d’alta fascia paiono oggi disposte a rilanciare, grazie a un’idea intima, elegante e al tempo stesso enigmatica, che riesce a spingersi ben oltre la moda della mindfulness o del coaching.
Non a caso, nell’edizione 2022 del FuoriSalone di Milano l’architetto Raffaello Galiotto ha voluto stimolare una grande riflessione sulla Design-Regeneration passando proprio per un’installazione denominata Labyrinth Garden, all’interno del Cortile del Settecento della Ca’ Granda: in quanto “progetto multicorsale outdoor”, realizzato con elementi divisori in plastica riciclata e piante verticali, il percorso non si risolve in una risposta (la via d’uscita può infatti essere scorta solo dall’alto di una torre centrale), ma la esibisce in atto.
Senza un cambio radicale di prospettiva, non solo il labirinto pare perciò destinato a tornare e ritornare dalla notte dei tempi, ma a condurre al temuto incontro con quell’invisibile Minotauro che resta annidato nel profondo dell’uomo contemporaneo. Non sempre la cura, infatti, sta nel trovare uno sbocco: come mostra l’arte decorativa di Giulia Meregalli, occorre trasformare le proprie pieghe imperscrutabili nell’eden dell’homo novus. L’uomo che riconosce e accetta il limite dell’abitabilità, salvandosi infine dall’hybris.
Ti è piaciuto questo contenuto? Condividilo con chi vuoi
TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

Uno spazio all'aperto pensato come esperienza, dove ogni dettaglio è progettato per fondere comfort, design e innovazione
Uno spazio all'aperto pensato come esperienza, dove ogni dettaglio è progettato per fondere comfort, design e innovazione

Contract • Design • Ospitalità
The Glowing Track è il nuovo sistema modulare d'illuminazione che unisce design e performance in una soluzione flessibile
The Glowing Track è il nuovo sistema modulare d'illuminazione che unisce design e performance in una soluzione flessibile

La struttura continua il suo programma di sviluppo con il restyling di Villa Ines, storica dimora immersa nel parco di Villa Radici
La struttura continua il suo programma di sviluppo con il restyling di Villa Ines, storica dimora immersa nel parco di Villa Radici