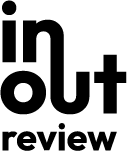Il progetto è qualcosa di vivo, fatto anche di tentativi che a volte non vanno nella direzione giusta. Ma il progetto in sé dev’essere un percorso intellettuale che in qualche modo permette di imparare e mantenere alto l’entusiasmo. Fondamentale arrivare a progettare non un edificio senza vita, ma un contenitore pulsante e popolato di persone che usufruiscono dei suoi spazi e dei suoi servizi. Piero Lissoni è uno sperimentatore che non conosce soste, amante delle logiche sottrattive tanto da essere stato spesso etichettato come minimalista. Una definizione che in qualche modo gli sta un po’ stretta, come evidenzia in questa intervista con InOut Review. Un incontro dove svela alcuni dei segreti del suo processo creativo.
Architetto e designer: è importante essere entrambi per avere un approccio completo verso la progettazione?
Guardi, per me non è possibile discernere queste cose tra loro. Culturalmente parlando, la mia visione fa parte di un approccio molto umanistico, che arriva dal Politecnico di Milano. Quando progetti un edificio, pensi anche a come le persone vivranno quel luogo, come si muoveranno, cosa vedranno, cosa toccheranno. Allo stesso tempo, quando disegni un mobile o un oggetto tieni conto di come esso si inserirà in uno spazio più grande.
La sensibilità del designer ai materiali, alle texture e ai dettagli si fonde con la capacità dell’architetto di leggere lo spazio, la luce e il contesto.
Come avviene la genesi dei suoi progetti creativi? Vi sono dei passaggi comuni che caratterizzano le sue diverse realizzazioni?
Il progetto è un percorso intellettuale, una disciplina, un processo: si studia, si prova, si cambia, e di nuovo si studia, si prova, si cambia e comincia il progetto. Poi ogni progetto nasce da un dialogo e da un dibattito quotidiano, da una strettissima collaborazione con il committente.
Quale idea di fondo guida i suoi progetti nell’hospitality?
Cerco sempre di adattarmi ai luoghi e di salvare l’anima locale, il genius loci, a livello intellettuale e culturale.
Questo vuol dire prendere alcuni elementi che possono essere estetici o produttivi, industriali o di scelta dei materiali, e interpretarli attraverso il mio linguaggio progettuale.
Nelle sue creazioni l’aspetto fondamentale è la commistione di stili, elementi e materiali. In quale albergo ha adottato questa sua filosofia?
Possiamo parlare per esempio di Dorothea Hotel a Budapest, l’ultimo progetto. La contaminazione è il concetto che contraddistingue il modello dello studio ed è quello che abbiamo cercato di portare anche qui. Abbiamo preso ispirazione dalla cultura locale, ma rivisitata in maniera contemporanea. La lobby è caratterizzata da grandi composizioni di bassorilievi in cemento che reinterpretano soggetti decorativi della tradizione ungherese e dalle ceramiche blu che rivestono il volume della scala preesistente, una riedizione attualizzata delle piastrelle Zsolnay. La stessa idea è utilizzata per le scandole nei diversi toni del blu che rivestono il bancone dell’Anton Bar & Deli. Un altro esempio è l’utilizzo del tradizionale motivo ungherese “soutache” reinterpretato graficamente su alcuni elementi, come i tappeti nei corridoi. Abbiamo utilizzato maestranze locali per le finiture, mentre tutti gli arredi sono importati da aziende del design italiano o realizzati su misura proprio per ottenere un mix di culture e linguaggi.
Siete sempre più impegnati nella sostenibilità. Quali sono gli ideali che ispirano il suo lavoro?
Lavoriamo da più di 20 anni su soluzioni innovative, disegniamo spazi pubblici e privati, zone di lavoro, uffici, fabbriche sempre con l’idea che debbano avere un’impronta realmente sostenibile. E lo facciamo controllando gli scambi termici, diminuendo al massimo la quantità di elementi legati al riscaldamento e al raffreddamento. Quindi cerchiamo il più possibile di progettare edifici che quanto meno arrivino in una condizione neutra: tanto consumano, tanto producono.
Alcune delle sue realizzazioni, come appunto il Dorothea Hotel, Autograph Collection di Budapest o lo Shangri-La Shougang Park di Pechino, si caratterizzano per l’essenzialità dell’interior design. Fa suo il motto “less is more”?
Sono spesso etichettato come minimalista, ma in generale mi riconosco in un approccio che evita eccessi di decorazione e segue un codice di eleganza, a volte rischioso, basato sulla ricerca di accostamenti e proporzioni che diventano nuovi codici.
Come si immagina il design del futuro? La genialità e la mano dell’architetto saranno ancora decisive?
Il design è una disciplina formidabile, per poter guardare verso il futuro dev’essere un perfetto equilibrio tra modelli razionali e la capacità anarchica di spostare linguaggi. Ma nessun creativo al mondo può fare il suo lavoro senza un imprenditore dall’altra parte. È un approccio che richiede di fare delle scelte: la scelta di investire, di trasformare le idee in realtà, mantenendo un dialogo costante tra l’imprenditore e il designer o l’architetto.
Quello che vedo nel futuro è una specie di gentrificazione, quello che viene pensato e prodotto in Italia è sempre più un pensiero mondiale.
Percepisco uno straordinario miglioramento qualitativo a tutti i livelli: grandi riflessi tecnologici e nello stesso tempo un’apertura a 360 gradi sui mercati di tutto il mondo.
Ti è piaciuto questo contenuto? Condividilo con chi vuoi
TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

Design • News • Ospitalità
ovre.design® firma gli alloggi di Via Roma Apartments e omaggia il grande cinema di Wes Anderson, Paolo Sorrentino, Pedro Almodovar e Sergio Leone
ovre.design® firma gli alloggi di Via Roma Apartments e omaggia il grande cinema di Wes Anderson, Paolo Sorrentino, Pedro Almodovar e Sergio Leone

Contract • Design • News • Ospitalità
Lo storico beach club si trasforma con strutture versatili il cui stile richiama suggestioni africane con uno sguardo contemporaneo
Lo storico beach club si trasforma con strutture versatili il cui stile richiama suggestioni africane con uno sguardo contemporaneo

Contract • Design • Hotellerie • News
Il progetto di Marianne Tiegen Interiors ruota intorno al fascino storico della struttura e a un'idea di esclusività basata sul sapere artigiano
Il progetto di Marianne Tiegen Interiors ruota intorno al fascino storico della struttura e a un'idea di esclusività basata sul sapere artigiano