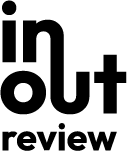Restituire una dimensione umana agli spazi in cui viviamo. A questo, oggi, è chiamata l’architettura, in uno sforzo di revisione dei “non luoghi”, gli spazi che, secondo l’antropologo Marc Augé, si contrappongono ai luoghi antropologici e che, quindi, hanno la peculiarità di non essere identitari, relazionali e storici.
Indifferenziazione e omologazione, infatti, sono vocaboli che stanno oggi assumendo un significato sempre più negativo soprattutto in un ambito come quello dell’hospitality, in cui i clienti chiedono alle strutture ricettive di recuperare l’identità locale e il radicamento nel territorio. Una venustas, dunque, che va oltre l’opulenza degli arredi o l’eccellenza del servizio e diventa sinonimo di armonia tra forma, funzione e ambiente. Una bellezza che, come spiegava Gio Ponti, trascende la dimensione estetica, per assumerne una etica e sociale.
Il rapporto con la bellezza è, per gli architetti, quotidiano e ciascuno la intende a modo suo, in un processo continuo di rielaborazione dei canoni classici che sfocia necessariamente in una visione soggettiva del bello, pur senza prescindere dalle inevitabili regole dell’equilibrio e dell’armonia. Esiste, dunque, un criterio oggettivo, come spiega Ludovica Serafini, fondatrice, insieme a Roberto Palomba, di Palomba Serafini Associati : “L’immagine dell’uomo vitruviano di Leonardo è tuttora valida – sostiene -: l’essere umano riesce a creare solo ciò che gli assomiglia e l’uomo è, dunque, al centro delle sue creazioni. Per questo più che di bellezza preferisco parlare di ‘buona proporzione’, intesa come equilibrio di lunghezza, larghezza e altezza. Un canone oggettivo, perché è sulla base di questo che definiamo uno spazio”.
Stabilita la norma gli architetti rivendicano, però, la libertà di poterla reinterpretare.
“Esiste un bello oggettivo – spiega Bepi Povia – e poi uno soggettivo, interiore, che viene fuori dalla sostanza, non dalla forma”.
“Siamo altamente allergici alle regole imposte in modo rigido, a quelle prescrizioni tecniche che vengono presentate come verità assolute – rivendica Stefan Rier, fondatore con Lukas Rungger dello Studio NOA -. Ogni architetto, ogni studio, dovrebbero costruire un proprio codice etico e progettuale, piuttosto che aderire ciecamente a dogmi esterni senza considerare il contesto, il progetto, l’intenzione architettonica”.

Il Rifugio Zallinger, sull’Alpe di Siusi, di cui lo Studio NOA ha curato il restyling e l’ampliamento – ©AlexFilz
“I canoni classici – aggiunge Gian Paolo Venier (partner di Paola Navone in OTTO Studio) – non si dimenticano, si stratificano dentro di noi, sono inevitabili. Ciò non toglie che noi, con la consapevolezza della regola, possiamo decidere di derogare”.
Ovviamente, però, la destrutturazione fine a se stessa non porta a nulla: “Dev’esserci un’idea, un pensiero che la guida, altrimenti si tratta solo di un gioco sterile. Conoscere le regole è indispensabile per poter guardare oltre e, se decido di liberarmi da un vincolo, il percepito dev’essere comunque gradevole: è l’obiettivo che cambia, non l’approccio”.
“È un tema su cui rifletto spesso – sottolinea Armando Bruno, socio e ceo dello Studio Marco Piva -. L’architettura ha oscillato sempre tra esperienza singola e linguaggio universale e anch’io, a un certo punto della mia vita professionale, ho messo tutto in crisi, ho voluto scardinare tematiche ormai consolidate”.
Ecco che, dunque, la bellezza diventa un concetto plurale, stratificato, soggettivo, “ma non per questo privo di responsabilità – sottolinea Marcello Ziliani, specializzato in design di prodotto -. Esistono ancora dei canoni, ma sono più liquidi, più legati al contesto culturale, al senso del luogo, alle istanze sociali e ambientali. In questo senso la bellezza non è più solo forma, ma anche processo, relazione, impatto”.
Gli fa eco il giovane architetto Elisa Panzarini: “Se una volta proporzione, simmetria, armonia erano gli unici concetti che definivano il bello, oggi tutto è più fluido, più soggettivo – sostiene -. Intendiamoci, le regole a livello di coerenza progettuale ovviamente ci vogliono, ma non bastano più”.
C’è poi chi, come Stefan Rier, non fa della bellezza il punto di partenza dei propri progetti: “Simmetria, ordine, calore, ripetizione sono tutti strumenti che appartengono al linguaggio architettonico, ma non sono fini a se stessi, sono appunto strumenti – sottolinea -. Il nostro obiettivo non è ‘fare qualcosa di bello’, ma creare spazi capaci di mettere chi li vive in vibrazione emotiva”.
“Nelle nostre architetture – aggiunge Rier – il punto di partenza è sempre l’organizzazione funzionale dello spazio: si parte da un organigramma, dalla logica dei percorsi, dalla fruibilità per l’utente. È da questa rete di relazioni e flussi che nasce lo spazio architettonico. Solo successivamente si stratificano quegli elementi che generano emozione, senso e per alcuni, bellezza”.
Ma una volta rivendicata la libertà di reinterpretare e superare le regole, fin dove ci si può spingere?

Una camera del Cambria Hotel di Nashville (architetto Nicola De Pellegrini)
“Per me – ci spiega Nicola De Pellegrini – ogni elemento progettuale deve avere una precisa ragione o funzione. La libertà di esplorare nuove soluzioni, di spingersi oltre limiti consolidati è importante, ma credo fermamente che la soglia da non superare mai sia quella dell’inutile”.
Per lui, dunque, la bellezza architettonica contemporanea dev’essere frutto di un progetto consapevole, dove tutto ciò che viene concepito e realizzato abbia un senso preciso e giustificato, evitando eccessi puramente estetici o forme fini a se stesse. Concorda con lui Bepi Povia: “Il limite – spiega – è non snaturare quello che c’è già. Faccio l’esempio di uno dei miei progetti, la Masseria AuraTerrae a Polignano a Mare: qui abbiamo deciso di sottrarre l’approccio paesaggistico-ornamentale per ridare vita all’antico ruolo agricolo che la masseria rivestiva. Un elaborato processo di ‘design delle radici’, il nostro, che ha avuto il suo fulcro nel recupero della memoria storica del luogo, ascoltando gli abitanti del territorio e, in base ai loro racconti, ripristinando colture come, ad esempio, l’antica vigna. Poi solo successivamente si è innestata la commistione tra agricoltura e hospitality”.
E Ziliani individua, nel processo creativo dell’architetto, nuovi vincoli “forse più complessi e più etici: parliamo di sostenibilità ambientale, inclusività sociale, rigenerazione urbana, dialogo con il patrimonio esistente. Il progettista può reinventare o provocare, ma non può più ignorare le conseguenze delle sue scelte”.
A riportare la discussione su un piano più pragmatico è Venier: “Il limite che ha oggi la creatività – ci dice – è quello che ci pone la redditività del progetto. Il budget che ci dà il cliente va rispettato e la resa economica è il vero limite”.

Il Fresh Hotel Athens, Progetto OTTO Studio – Courtesy of Fresh Hotel
Concorda con lui Armando Bruno, che spiega come nell’hospitality siano proprietà e gestore a tarpare le ali alla creatività e fa degli esempi pratici: “Fosse per me – spiega – io farei del letto l’elemento centrale della camera d’albergo e lascerei tutto il perimetro libero, chiudendo solo la parte sanitaria. Spesso, tuttavia, mi devo scontrare con consuetudini dure a morire – continua -, come mettere il telefono sul comodino. Ma oggi, con gli smartphone, cosa me ne faccio di un apparecchio fisso? La stessa cosa vale per lo scrittoio in camera: che senso ha, con gli spazi comuni e di coworking sempre più sviluppati?”.
“In compenso – aggiunge Armando Bruno – non ci sono portavaligie, oppure sono troppo bassi e appoggiati alla parete. E allora io finisco per usare lo scrittoio stesso come portavaligie… Inutile dire che tutto questo non giova all’estetica della camera”.
In ogni caso la bellezza, spiega Serafini, deve andare di pari passo con l’efficienza: “Io progetto l’oggetto – spiega – in base al criterio della buona proporzione, la funzione la dà l’azienda. Il progetto deve, dunque, dare emozione alla funzione, che noi diamo per scontata”.
Concorda con lei Rier: “Bellezza ed efficienza non sono in contrapposizione, anzi – precisa -: senza efficienza, non esiste vera bellezza. Un progetto bello ma inefficace, che non funziona nella vita reale, è solo un’immagine, un esercizio stilistico. Al contrario – aggiunge -, quando uno spazio è pensato per essere realmente vissuto, quando risponde in modo intelligente alle necessità delle persone e dell’ambiente, lì nasce una bellezza autentica, che si percepisce anche senza doverla spiegare”.
Gli fa eco Armando Bruno: “In passato – racconta – il prodotto di design si è mosso a prescindere dalla funzionalità per diventare esso stesso oggetto d’arte fine a se stesso, un po’ come è accaduto per l’alta moda. Anche nell’interior design, però, la bellezza deve necessariamente coniugarsi con la funzionalità: se l’utente non può usufruire di un prodotto, non ne viene appagato”.
Bellezza ed efficienza, dunque, sono strettamente interconnesse e non possono più essere considerate separatamente. “Non si tratta solo di una bellezza visiva o percepita – spiega De Pellegrini -, bensì di una bellezza concreta, tangibile, reale. Una bellezza che coinvolge tutti i sensi e si manifesta soprattutto attraverso l’efficienza, il comfort e la funzionalità degli ambienti”.

Como Le Montrachet – Paola Navone OTTO Studio
Quasi tutti gli architetti concordano, dunque, sul fatto che il bello, per lasciare un ricordo duraturo, non debba essere autoreferenziale, bensì connesso al contesto, alla cultura locale, alle esigenze dell’ospite. “Determinante – evidenzia Panzarini – dev’essere, quindi, la capacità di creare uno storytelling per comunicare messaggi e dar vita a un’esperienza coinvolgente”.
In questo contesto l’hotel è da intendersi come ‘public area’ fruibile per tutti e in grado di raccontare a tutti una storia. Ma non solo: la definizione stessa del concetto di bello include, oggi, anche il gesto etico che, secondo Panzarini, è proprio mettere al centro l’identità del luogo: “Fondamentale, a questo proposito, concentrarsi sia sulla sostenibilità, un aspetto ormai imprescindibile del progetto, sia sull’utilizzo di materiali locali e lavorazioni artigianali, nel segno del rispetto del territorio”.
E se proprio quest’ultimo tema è al centro dei progetti di Povia, l’attenzione alle radici è fondamentale anche per Serafini: “Se tolgo l’identità del luogo – spiega – perché dovrei andare proprio lì? L’eticità di un progetto sta anche nel suo radicamento sul territorio, nel saper mantenere l’identità contemporaneizzandola”.
Una discussione in cui si inserisce una voce fuori dal coro: quella di Armando Bruno. “A me – dice provocatoriamente – il territorio non interessa. Chi l’ha detto che un cliente che va a Capri deve sentirsi per forza a Capri? Il concetto di ‘casa fuori da casa’, poi, con l’albergo non c’entra: l’hotel non è una casa, ci dormo poche notti e devo vivere un’esperienza diversa da casa mia”. Piuttosto che mettere a forza in una struttura richiami generici e banali al territorio meglio, per lui, renderla avulsa dal territorio stesso.
“Fare architettura tralasciando la connessione con il territorio non è la nostra pratica, non lo condividiamo – ribatte Rier -. Ma non è solo l’architetto che si deve porre in relazione con il territorio; anche l’albergatore deve trasportare e trasmettere significati aggiuntivi”.
Forse, allora, il significato di bello oggi sta proprio in questo: nella capacità del progetto di ‘risignificare’ un luogo, dando vita a una struttura a dimensione umana da contrapporre allo spazio globale che la nostra epoca propone.
Ti è piaciuto questo contenuto? Condividilo con chi vuoi
TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE

Assegnati a Rimini i premi della prima edizione degli ADI-InOut Hospitality Awards. Al centro estetica e tecnologia
Assegnati a Rimini i premi della prima edizione degli ADI-InOut Hospitality Awards. Al centro estetica e tecnologia

Design • News • Ospitalità
Le aree di sosta degli aeroporti e le hall degli alberghi non sono più non-luoghi di transito: progettazione, arte e comfort li trasformano in esperienze vive, spazi narrativi che umanizzano il tempo dell'attesa
Le aree di sosta degli aeroporti e le hall degli alberghi non sono più non-luoghi di transito: progettazione, arte e comfort li trasformano in esperienze vive, spazi narrativi che umanizzano il tempo dell'attesa

Un numero ricco di inchieste e spunti di riflessione a cominciare dal servizio di apertura, che invita i lettori a scoprire le nuove sfumature del bello in architettura
Un numero ricco di inchieste e spunti di riflessione a cominciare dal servizio di apertura, che invita i lettori a scoprire le nuove sfumature del bello in architettura